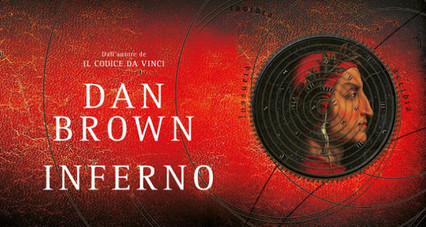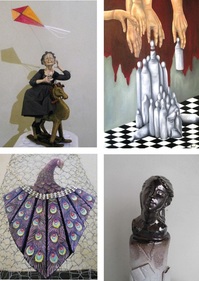“Tiempe belle ’e na vota, tiempe belle addó state” chiede, nostalgica, una celebre canzone classica napoletana; e se l’arte è la capacità di sviluppare in maniera soggettiva (perché l’opera interessi con la sua novità) una realtà oggettivamente riconosciuta (perché sia facilmente compresa dal fruitore), il fascino sortito da quella composizione non può che confermare che il rimpianto di tempi andati è sempre stato presente nell’uomo di ogni epoca, dai lirici vagheggiamenti dell’Arcadia ai più ordinari ricordi individuali della giovinezza.
Ma è poi veramente così? Lo scorrere del tempo è un così penoso, inevitabile precipizio per l’umanità?
A guardare il progresso a tutt’oggi avvenuto, la possibilità di affrancamento da tante fatiche fisiche, l’allungamento medio della vita di ognuno di noi, l’avvenuta abolizione di certi privilegi e poteri che sarebbe certo ben più corretto chiamare soprusi istituzionalizzati, come la schiavitù, la tortura, l’autodafé o certa censura, e l’oggettivo miglioramento della possibilità di più felice vivibilità (a sapersela conquistare), si direbbe proprio di no.
E allora dov’è la soluzione dell’arcano? Di questa latente o ben manifesta insoddisfazione del presente?
Con ogni probabilità, o comunque buona incidenza, in un particolare spontaneo atteggiamento che permette alle società umane, consapevolmente o meno, di migliorarsi.
È l’atteggiamento per il quale siamo così inclini a raffigurare ai giovani, specialmente nei loro primi anni di vita, attraverso racconti, esempi, stili di vita, insomma per mezzo dell’educazione, un mondo ideale, fatto di valori come equità, giustizia, onestà, correttezza, sincerità, e chi più ne ha più ne metta. Il fanciullo finisce così con l’acquisire, soprattutto nei primi anni della sua esistenza, quelli riconosciuti come i più ricettivi e psicologicamente formativi, una visione della realtà idilliaca ed ideale, ma ideale secondo una desiderata idealità degli adulti, senza avvedersi che, intorno a lui, in fin dei conti, ben difficilmente troverà la giustizia, l’equità e tutto il resto, almeno per come gli sono state fatte intendere. Non le troverà certo nella preda impunemente sbranata dal predatore, in tante sperequazioni sociali, in tante disparità fisiche, in un mondo dove non giunge sempre un cacciatore a salvare Cappuccetto Rosso, un principe a invaghirsi di Biancaneve, tantomeno impalmare la Cenerentola di turno.
Il risultato di questa dicotomia è che il giovane, crescendo, incapperà, prima o poi, in una realtà più autentica, meno edulcorata, traumatizzante.
Ci saranno allora, sostanzialmente, due diverse possibili reazioni da parte sua.
Se avrà un’autostima opportunamente coltivata da successi riportati e da equa stima altrui, ritenendo il mondo cambiato negativamente, si prodigherà per il ripristino del rimpianto status quo. Vivrà da idealista, sacrificando se stesso per le sue idee e per la collettività. Sarà scienziato, artista, filosofo, missionario, martire o eroe, inclinerà a grandi imprese, sempre sostanziate da grande passione, e i suoi valori resteranno quelli primigeni.
Ma se la consapevolezza di sé sarà invece bassa, entrerà nel popoloso novero di un penoso gregge umano, di una massa inerziale sociale acquiescente, facile preda di mode, manipolazione e valori epocali, qualunque essi siano. Sarà uomo qualunque, senza particolari virtù, un individuo ordinario che vive di piccole, inutili cose, piaceri vacui, lasciando poi ben piccola traccia sociale del suo passaggio su questa terra, il cittadino irreggimentato, il ladro di polli, il piccolo truffatore, il parassita sociale invidioso e represso, tenacemente attaccato alla vita, che non saprà vivere con vera passione, ma con misera passività, secondo mode e valori altrui.
E giacché è noto che la natura impone il sacrificio del singolo per la tutela della specie, il martirio, non di rado lungo un’intera vita, di ogni nobile idealista, servirà allora ad elevare, seppur lievemente, il resto dell’umanità, ma sempre, ognuno, malinconicamente rimpiangendo felici tempi andati.
Ma è poi veramente così? Lo scorrere del tempo è un così penoso, inevitabile precipizio per l’umanità?
A guardare il progresso a tutt’oggi avvenuto, la possibilità di affrancamento da tante fatiche fisiche, l’allungamento medio della vita di ognuno di noi, l’avvenuta abolizione di certi privilegi e poteri che sarebbe certo ben più corretto chiamare soprusi istituzionalizzati, come la schiavitù, la tortura, l’autodafé o certa censura, e l’oggettivo miglioramento della possibilità di più felice vivibilità (a sapersela conquistare), si direbbe proprio di no.
E allora dov’è la soluzione dell’arcano? Di questa latente o ben manifesta insoddisfazione del presente?
Con ogni probabilità, o comunque buona incidenza, in un particolare spontaneo atteggiamento che permette alle società umane, consapevolmente o meno, di migliorarsi.
È l’atteggiamento per il quale siamo così inclini a raffigurare ai giovani, specialmente nei loro primi anni di vita, attraverso racconti, esempi, stili di vita, insomma per mezzo dell’educazione, un mondo ideale, fatto di valori come equità, giustizia, onestà, correttezza, sincerità, e chi più ne ha più ne metta. Il fanciullo finisce così con l’acquisire, soprattutto nei primi anni della sua esistenza, quelli riconosciuti come i più ricettivi e psicologicamente formativi, una visione della realtà idilliaca ed ideale, ma ideale secondo una desiderata idealità degli adulti, senza avvedersi che, intorno a lui, in fin dei conti, ben difficilmente troverà la giustizia, l’equità e tutto il resto, almeno per come gli sono state fatte intendere. Non le troverà certo nella preda impunemente sbranata dal predatore, in tante sperequazioni sociali, in tante disparità fisiche, in un mondo dove non giunge sempre un cacciatore a salvare Cappuccetto Rosso, un principe a invaghirsi di Biancaneve, tantomeno impalmare la Cenerentola di turno.
Il risultato di questa dicotomia è che il giovane, crescendo, incapperà, prima o poi, in una realtà più autentica, meno edulcorata, traumatizzante.
Ci saranno allora, sostanzialmente, due diverse possibili reazioni da parte sua.
Se avrà un’autostima opportunamente coltivata da successi riportati e da equa stima altrui, ritenendo il mondo cambiato negativamente, si prodigherà per il ripristino del rimpianto status quo. Vivrà da idealista, sacrificando se stesso per le sue idee e per la collettività. Sarà scienziato, artista, filosofo, missionario, martire o eroe, inclinerà a grandi imprese, sempre sostanziate da grande passione, e i suoi valori resteranno quelli primigeni.
Ma se la consapevolezza di sé sarà invece bassa, entrerà nel popoloso novero di un penoso gregge umano, di una massa inerziale sociale acquiescente, facile preda di mode, manipolazione e valori epocali, qualunque essi siano. Sarà uomo qualunque, senza particolari virtù, un individuo ordinario che vive di piccole, inutili cose, piaceri vacui, lasciando poi ben piccola traccia sociale del suo passaggio su questa terra, il cittadino irreggimentato, il ladro di polli, il piccolo truffatore, il parassita sociale invidioso e represso, tenacemente attaccato alla vita, che non saprà vivere con vera passione, ma con misera passività, secondo mode e valori altrui.
E giacché è noto che la natura impone il sacrificio del singolo per la tutela della specie, il martirio, non di rado lungo un’intera vita, di ogni nobile idealista, servirà allora ad elevare, seppur lievemente, il resto dell’umanità, ma sempre, ognuno, malinconicamente rimpiangendo felici tempi andati.